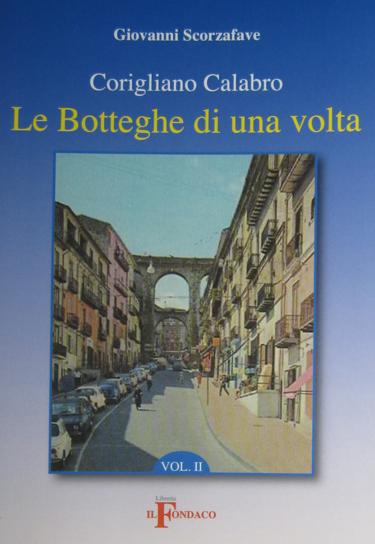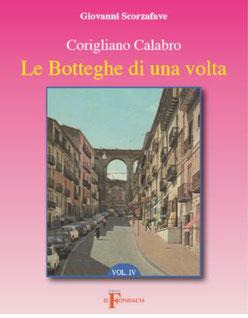I miei Personaggi
Ricordi
(cliccare sulle immagini per ingrandirle)

PREFAZIONE
Da qualche tempo, con lo spirito di non sprecare gli anni che mi restano ancora da vivere, che – ahimè - sono molto di meno rispetto a quelli già vissuti, ho intrapreso un percorso di ricerca e di documentazione sulla mia città natale, dedicandole un sito web (www.coriglianocal.it.); niente di particolare, sono soltanto pagine scritte con la penna del cuore e trasportate dal vento della memoria, erranti in questo mondo moderno, ma sempre più piccolo e povero di valori.
Qui, ogni lettore può consultare ciò che inserisco quotidianamente, notizie, racconti, foto storiche, aneddoti e ancora altro, che ritengo siano utili alle nuove generazioni perché conoscano di più e meglio le nostre radici.
Gli argomenti sono molti (tanti pure i visitatori) e non mancano notizie biografiche su alcuni uomini, che si sono distinti nella nostra città per opere ed impegno, fatti e storie, che hanno goduto di qualche popolarità, come scrittori, medici, artisti, poeti, amministratori e altri.
Già gli “altri”, ma chi sono costoro? Sono uomini comuni. Correvano ancora gli ultimi anni dello scorso millennio quando decidevo di dedicare un po’ di spazio, oltre alle stradine acciottolate dai colori della vita ’i ri vicinanzi (dei vicinati), ai commercianti, che animavano di mercanzie ed arte ’i putighi (le botteghe), anche agli uomini semplici, umili e noti per la loro grande popolarità.
Era questa la “mia” città, quella di tutti, ove si viveva certamente con difficoltà e sacrifici, ma con onestà e rispetto, senza alcuna distinzione di sesso, di età, di lingua, di razza, di religione, di opinioni politiche o di mille altre contraddizioni sociali.
Sì, perché gli “altri” erano anch’essi miei concittadini, forse anche degli “humiles” di manzoniana memoria, ma che hanno contribuito pure loro alla storia cittadina.
Anzi, quali semplici persone, oneste, infaticabili, senza filtri, vivendo a volte ai margini della società, che li considerava essenziali, ma non importanti o degni di considerazione, con poche risorse materiali e molte umane, hanno fatto tutto ciò che era possibile fare, a volte anche l’impossibile.
Gli “altri” sono questi, tutte quelle persone che hanno lavorato e lavorano nell’ombra, nell’anonimato, nel silenzio assordante della prevaricazione e della prepotenza sociale. Sono queste le persone, risplendenti di solitudine, che resteranno per sempre ben impresse nella mia memoria.
Con curiosità e simpatia restavo colpito da loro quando li vedevo passare da casa mia, nell’antica contrada della Grecìa (oggi al civico 6 di via Carso), oppure quando mi recavo dalla mia cara nonna, za ’Ntunetta, a ru Fuossi Bianchi (Largo Pasquale Curti), attraversando l’Acquanova, gremita di gente di ogni condizione sociale, dove non mancavano anche gli “altri”, sempre in cerca di ritrovare la propria serenità offuscata da uomini che facevano della calunnia il loro stile di vita.
Erano uomini di fatica, banditori, ambulanti, che vendevano tutto e di più, sagrestani, bocche di rose, nobili che vivevano segregati in famiglia, musicisti itineranti, artigiani dalle mani ruvide e nodose, che spesso per un piatto di lenticchie, ma a volte anche meno, svolgevano lavori particolarmente faticosi e umili, donne che in perfetto equilibrio scorrevano lentamente reggendo una cesta in vimini piena di panni sulla testa, appoggiandola supra ’u stifagni (cercine di tessuto), dirette verso le limpide e fresche acque del torrente Coriglianeto a lavare panni.
Erano, altresì, uomini e donne del loro tempo, che hanno affrontato la vita nel dolore della povertà e della miseria, quasi sempre in piena solitudine, privi di ogni supporto morale e materiale e rapporto affettivo, spesso emarginati dai loro simili, da uomini senza scrupoli, senza rispetto, ma soprattutto senz’anima.
Sono stati questi “altri”, dotati di una grande sensibilità e di profondi sentimenti, che, con la loro bellezza d’animo e il loro coraggio di vivere senza farsi condizionare dai giudizi altrui, mi hanno insegnato molte cose, tra queste, in particolare, come affrontare le difficoltà della vita con lo spirito giusto e la voglia di non mollare mai.
Ecco perché mi piace definire impropriamente “miei personaggi” queste persone, perché li sento idealmente vicini al mio mondo interiore, fino a diventarne parte integrante, per distinguerli da quelli (guerrafondai) studiati a scuola su testi di storia, presentati come eroi, ma i cui nomi da tempo, come quei libri, giacciono inermi in un vecchio cassetto, pieno di ragnatele, nella buia soffitta dei miei ricordi.
Queste persone, “figli di un Dio minore”, talvolta sottomesse e incerte, altre volte, invece, ribelli e sicure, sono stati uomini e donne travolti da situazioni balorde e ipocrite, inventate e mistificate da falsi filosofi e dai naviganti dei mari dell’odio e dell’emarginazione, mentre altri, pur non possedendo alcun titolo di studio (analfabeti), sono stati dei veri artisti nel campo della musica e in quello del lavoro.
Ho riflettuto a lungo prima di decidere se pubblicare o meno questi racconti, che ho iniziato oltre venti anni fa.
Ero titubante perché certo di subire non poche critiche da parte di alcuni “benpensanti planetari”, che magari proveranno disgusto per queste mie pagine dedicate agli umili e agli “ultimi” perché magari avrebbero preferito che non se ne parlasse, cancellandone per sempre sui muri della memoria i nomi, ritenendoli un disonore per la città, mentre di altri scrivono i nomi, a carattere cubitali, sui muri della vanagloria.
Ebbene non l’ho fatto, perché appartengo ad un mondo diverso da quello di questi falsi moralisti, “esperti” di un conformismo alterato, che amano viaggiare sul treno del fariseismo.
Nel mio cammino non ho mai amato viaggiare in compagnia di costoro, che con la “virtù” dell’ipocrisia sanno solo dire: “lasciate in pace nei loro avelli queste persone che hanno già sofferto durante la loro vita”. A queste persone dico: “Perché lasciar dormire nei loro avelli solo alcune persone e le altre no? Forse non siamo tutti sotto lo stesso cielo figli dello stesso Dio?”
Ecco, questo è il vero motivo, per cui oggi, in netta contrapposizione con questi oscuri “viaggiatori dell’ambiguità”, ai quali consiglio di fermarsi alla sola lettura di questa mia prefazione, sono qui a ricordare alle nuove generazioni questi uomini e queste donne, con il loro nome, cognome, soprannome, a volte, quando mi è possibile, anche coi loro volti rugosi per la fatica e per la sofferenza.
Solo così si potrà ridare la dignità negata ad alcuni, mentre ad altri il giusto riconoscimento per avere condotto una vita all’insegna della famiglia e del lavoro, superando talvolta le dure e impervie salite della vita.
Concludo qui, con queste semplici riflessioni sincere, autentiche ed accorate note della loro vita, perché è giunto il momento di dare spazio all’inchiostro della mia penna, con buona pace dei “benpensanti”, ai quali mi piace ricordare un assioma, che la storia non è fatta dai “grandi”, ma dalla moltitudine di gente operosa e onesta, che ha saputo dare al nostro paese ed alla sua gente una grande lezione di vita.
Solo se avremo consapevolezza della memoria e delle opere di chi ci ha preceduto, sapremo essere degni dei nostri padri e potremo ricalcare le loro orme per diventare uomini migliori, figli di una terra generosa e spesso maltrattata, ma che ha saputo offrire la possibilità di riscatto, con sacrificio, umiltà, coraggio e fede in Dio.
Queste pagine sono dunque la voce di quei Coriglianesi umili, ma ricchi di dignità e coraggio, scritte con la consapevolezza che “La vita è una lunga lezione di umiltà” (James M. Barrie).
Giovanni Scorzafave

PRESENTAZIONE
di Rinaldo Longo
Giovanni Scorzafave chiude la sua prefazione a questo libro affermando che le pagine in esso contenute “sono la voce di quei Coriglianesi umili, ma ricchi di dignità e coraggio, scritte con la consapevolezza che <<la vita è una lunga lezione di umiltà>>”. La citazione che egli riporta è presa a prestito da James M. Barrie che è il noto creatore del personaggio di Peter Pan in un suo romanzo (ma anche in un suo testo teatrale) dal titolo Peter e Wendy (1904). È vero.
Ci sono molti elementi in questo libro che ho l’onore di presentarvi che possono richiamare il personaggio di Peter Pan e la “sindrome di Peter Pan”, della quale in psicologia si parla dal 1983 e che consiste in una condizione psicologica patologica in cui una persona si rifiuta di operare nel mondo degli “adulti”, in quanto lo ritiene un mondo ostile, e si rifugia in comportamenti e in regole comportamentali tipiche della fanciullezza. Naturalmente per tanti, il volare verso “l’isola che non c’è” comporta vivere la propria vita scontrandosi con una realtà e con pirati che li emarginano e/o li sfruttano derubandoli e togliendo loro persino la stessa vita.
Nell’antica Grecia Socrate è un umile che consacra la sua vita alla ricerca della saggezza ed è costretto a morire suicida. Nell’antica Roma umile è il comportamento del poeta e filosofo epicureo Lucrezio che si rifiuta di schierarsi con il potere: egli non è il romano che vuole fare la guerra e purtroppo muore suicida. È dura la vita del giovane umile o dell’adulto umile, siano essi di estrazione sociale ricca che povera.
Come che sia bisogna convenire che l’umiltà è necessaria e fondamentale per accettare ciò che non si può cambiare, che il coraggio è necessario per cambiare ciò che non si deve accettare, che la saggezza è necessaria per riuscire a distinguere tra cosa si può e cosa non si può cambiare. Queste tre qualità (umiltà, coraggio e saggezza) devono essere assistite e supportate, a mio avviso, dalle tre virtù teologali: Fede, Speranza e Carità. Soprattutto la carità, come ci indica San Francesco di Paola, è fonte di emotività positiva per la conquista di una spiritualità garante del benessere psichico e fisico. In chi è privo di umiltà e carità non alberga nessun alito vitale.
Le storie coriglianesi narrate in questo libro potrebbero sembrare fantasiose e anacronistiche e invece no, sono vere, sono storie-documento appassionate e vive, filtrate attraverso un crivello di vibrazioni emozionali che non inquina la verità, e portatrici di una lezione che, iniziata con il Naturalismo francese (Émile Zola e i fratelli Edmond e Jules de Goncourt) e con il Verismo di Giovanni Verga, si collega a quella del neo-realismo nel campo della letteratura (Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia), dell’arte figurativa (Renato Guttuso) e del cinema (Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica). Proporle è una mossa non solo coraggiosa ma doverosa storicamente e leggerle è un diritto-dovere ai fini della conoscenza di cittadini ultimi ed umili della scala sociale nella Corigliano del XX.° secolo.
Il lettore è invitato a meditare sulla esperienza di vita (e, per alcuni casi, di alienazione sociale) di Ruminichielli ‘i trentatrreanni (Domenico Montillo), di Fofonzi u Napuliteni (Giovanni Alfonso Capaldo) e zu’ Francischi a Zirra (Francesco Iannini), di Spìriti Maligni (Salvatore Affortunato), di Spirìti Pittineti e Gghjacinti u Nnamureti (Espedito Pettinato e Giacinto Cervino), di Sarbaturi u Re (Salvatore Casciaro), di Totonni u Crochiceri (Antonio Borgia), di Don Lisanni (Alessandro De Rosis), di Zù Franchi (?), di Giacomini ‘i ru sapuni (?), di Mastru Carri (Carlo Grispino), di Giorgi ‘i Frischirummi (Giorgio Manfredi), di i Quarareri (Giorgio Plastina e Antonio Bellito), di Sarbaturi u Pallisti (Salvatore Bonafede), di Battista u sacristeni (Battista Montalto), di Don Bennardo (Bennardo Longo), di i Vannieri: Gigi (Luigi Guarnieri), Baista (Battista Vulcano), Stanghetta (Giovanni e Francesco Montillo), e Antonio Santelli, e poi ancora di Assunta ‘i Mantavecchja (Assunta Catalano), di Luviggielli (Luigi Olivieri), di i Lavanneri (Genoveffa Veronese e Liberata Adimari), di Totonnielli’i ra carbunella (Antonio Mollo), di Ciccillo e Totonno Pittineti (Francesco e Antonio Pettinato), delle Bocche di rose (Jolanda e Filomena), di i Rafanielli (Alberto e Leonardo Sisto), di Giuvanni e Sarbaturi (Giovanni Manna e Salvatore Marinaro), di u Sergenti Maggiori (Francesco Pacino), di Vicienzi aFimminella (Vincenzo Turano).
I lettori attenti possono riscontrare di quanta umanità è carica la parola dell’autore nella descrizione di ognuno di questi personaggi.
Sono quasi tutti personaggi dei quali sia Giovanni Scorzafave che io, insieme a quasi tutti i coriglianesi viventi nel secolo scorso, abbiamo avuto una conoscenza diretta, anzi di Assunta Catalano (Assunta ‘i Mantavecchja) sono stato incaricato io stesso dallo Scorzafave a redigere le pagine che la riguardano. Per questo lo ringrazio. Su qualcuno di questi personaggi il libro contiene anche interessanti note dovute ad altri amici coriglianesi: il giornalista dott. Giuseppe Casciaro, il dott. Gerardo Bonifiglio, il dott. Luigi Petrone, il compianto dott. Angelo Foggia.
Ora, per alcuni lettori questi personaggi potrebbero sembrare secondari nella storia di Corigliano, o addirittura non meritevoli di essere raccontati, per me invece bene ha fatto Giovanni Scorzafave a trattare di loro in questo libro e a farli conoscere nella loro giusta dimensione alle generazioni viventi che non li hanno conosciuti e a quelle che verranno. Sapendo della loro vita abbiamo una base di partenza utile per conoscere implicitamente quelli della scala sociale più alta economicamente e culturalmente parlando.
Sicuramente l’autore di questo libro non ha intenzione di finire fra i tanti ignavi del tipo quelli del III canto dell’Inferno di Dante e nemmeno di appartenere alla grande schiera degli indifferenti contro i quali si scaglia Antonio Gramsci, il quale era convinto che “l’indifferenza è il peso morto della storia” (in A. Gramsci, Odio gli indifferenti, in “La città futura”, n. 1, 11 febbraio 1917). Scorzafave non si adegua alla massa, e nemmeno all’idea del più forte.
Dunque dalla lettura di questo libro di storie vere coriglianesi emerge un’esortazione sincera a saper prendere posizione riguardo alle vicende umane e a non essere spettatori passivi della storia. Infatti dall’episodio biblico del “roveto ardente” contenuto nel libro dell’Esodo si evince che bisogna attivarsi perché vi sia una conversione nel comportamento degli uomini che hanno il deserto dentro il loro cuore.
Gli umili normalmente vengono inquadrati fra ì cosiddetti ultimi e al più basso gradino della scala sociale, alcuni usano dire che stanno nella parte più bassa della stratificazione sociale. C’è un luogo però dove gli umili vengono considerati al gradino più alto dell’attenzione, questo luogo è il Vangelo di Cristo. Da qui ci arriva quanto può far luce sul tema del nostro discorso. Ebbene, l’evangelista Luca, riguardo alla necessità della penitenza, al cap. 13 versetti 1-9 riporta queste parole di Gesù: “se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo”. Questo è un grande monito rivolto agli uomini e in particolare a quelli che sospettano sempre delle colpe altrui.
Infatti gli uomini in genere sono portati a pensare che le disgrazie capitino sempre a chi ha fatto qualcosa per meritarsele, come se le violenze subite fossero un aspetto del giudizio divino verso le colpe altrui. Cioè c’è il sospetto che la violenza subita è una violenza meritata per cui spesso le vittime della violenza risultano sospette agli occhi altrui, ecco perché Gesù stigmatizza questo sospetto e dice “se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo”.
In verità Dio non castiga ma dice che senza consapevolezza delle proprie fragilità, e quindi senza cambiamento interiore, la vita umana sarà sconfitta non dalla violenza dei nemici, ma dall’orgoglio di essere più grandi, persino di Dio stesso.
Se mi consentite vorrei ancora cercare di toccare il cuore del lettore, sia che abbia o che non abbia fede in Cristo, con qualche riflessione su alcune parole riportate in Luca cap. 14, 1.7 – 14: “chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”. In queste parole appare chiaro che c’è qualcosa che ci invita ad andare controcorrente. Gesù ha rovesciato i potenti e innalzato gli umili. Nei versetti citati vengono dati due insegnamenti: il primo, rivolto a coloro che sono invitati, è quello di dare un chiaro esempio di umiltà, per esempio sedendosi agli ultimi posti, il secondo rivolto a colui che ha fatto l’invito ricordandogli che questo deve essere gratuito e contro la logica del contraccambio.
Ora bisogna convenire che in questi nostri tempi umiltà e gratuità sono due virtù rare e spesso identificate la prima con servilismo e la seconda con impoverimento. Eppure umiltà e gratuità sono due virtù che misurano il grado di umanità degli uomini. Insomma chi è invitato sia umile e chi invita lo faccia ma con gratuità. Conclusione: nessuna esaltazione del proprio valore e dei propri meriti e piena consapevolezza dei propri limiti. Pensate, la parola umiltà deriva da “humus” (cioè terra o meglio ‘cruopi’, letame) ed è questo che il nostro corpo ritornerà ad essere quando il Signore ci chiama.
Non a caso ho proposto la parola ‘crùopi’, infatti voglio porre la vostra attenzione sul valore semantico della radice indoeuropea *k o r (dove l’asterisco “*” indica che si tratta di una ricostruzione scientifica di questa radice e il cerchietto “o” indica che la radice è rappresentata con un grado vocalico zero tra le due consonanti, ma che in quella posizione si può presentare una qualsiasi delle cinque vocali. Cfr. https//bitculturali.it > 2013/04 “Legame etimologico tra corda, cuore, cervello e viscere” di Rinaldo Longo). Ebbene questa radice *k o r si trova in tutte le parole che hanno nel significato un qualche riferimento ad ‘alito vitale’, ‘vibrazione, movimento vitale’: es. Cristo, credere, Credo, Krišna, crèsima, Carità, crùopi, cuore, corda, cervello, vìscere (<vis+kere), Carlo (= uomo libero), cercare, còrrere, corpo, ecc.
Allora dicevamo che lo stesso Cristo ci avvisa di non esaltarci, di non ritenere di avere sempre ragione, ma di accogliere gli umili senza pretese di contraccambio. Dunque bisogna applicare la logica dell’amore e della gratuità, e questa è la logica che guida Giovanni Scorzafave in questo suo lavoro, quella logica comportamentale di cui ha avuto grandi esempi in suo zio Ciccillo Longo e nei suoi genitori, che ho conosciuti personalmente: il padre Gerardo Scorzafave e la madre Demetrina Montalto, mamma che possedeva l’umiltà di Maria madre di Gesù.
Ma vediamo cosa accomuna il grido degli ultimi e la pazienza degli umili. Papa Francesco lo ha chiarito benissimo nelle sue riflessioni durante la Via Crucis del marzo 2016. Leggendo le pagine di questo libro di Scorzafave vi verrà facile stabilire in quali riflessioni del Papa rientrano le esperienze di vita dei vari personaggi raccontati.
Nella prima stazione il Papa afferma: “Gli ‘ultimi” sono le vittime della cultura dello ‘scarto’”, quindi sono coloro che vengono umiliati. Infatti il comportamento di Pilato ci dice che “tra la vita e la verità egli sceglie la propria vita. Tra l’oggi e l’eternità egli sceglie l’oggi” e aggiunge che ciò è dovuto alla “paura del diverso (colpa della nostra poca Fede)”. Infatti così facendo Pilato umilia Gesù, ma nello stesso tempo non si accorge di aver dato una sterzata alla storia umana avviandola sulla strada dell’Uomo Nuovo.
Nella seconda stazione il Papa ci ricorda che “il cristiano accetta lo scherno e le umiliazioni che derivano dall’amore e dalla verità”.
Nella terza stazione egli afferma che “Dio è negli scarti, ultimo tra gli ultimi, naufrago tra i naufraghi”.
Nella quarta egli si sofferma sull’umiltà di Maria indicandola come “la pietra d‘angolo di ogni famiglia”, “l’architrave insostituibile delle relazioni umane”, “l’amore per sempre che salverà il mondo”.
Nella quinta stazione, quella in cui il Cireneo è costretto a portare la croce, Papa Francesco riflette sulle sofferenze umane e dice che esse “ci appaiono come una costrizione, talvolta persino un’ingiustizia”, come “ad esempio la nascita di un bambino disabile”. In realtà il fatto ci dice che dalla compassione nasce la solidarietà. Queste le parole del Papa: “Dio si sporca le mani con noi, con i nostri peccati e le nostre fragilità, non se ne vergogna e non ci abbandona”.
Nella sesta stazione, quella in cui la Veronica asciuga il volto di Gesù, egli ci ricorda che di fronte ai “volti sfigurati” dalle sofferenze, ai “milioni di profughi, rifugiati e sfollati che fuggono disperatamente dall’orrore delle guerre, dalle persecuzioni e dalle dittature” spesso si prova ribrezzo e non attenzione, invece “Dio è soccorritore coraggioso”.
E così procedendo con le meditazioni sulle sofferenze e le cadute di Gesù arrivato alla nona stazione Papa Francesco medita sulle sofferenze provocate da una “famiglia spezzata” e su chi trovandosi senza lavoro pensa di non avere più dignità, mentre alla decima si sofferma sulle “piaghe di dolore dei bambini profanati nella loro intimità”.
Continuando alla dodicesima egli si sofferma sui martiri di tutti i tempi e in particolare su quelli del XXI sec., i veri màrtiri del mondo contemporaneo.
Arrivati alla quattordicesima chiedo a Giovanni Scorzafave e a tutte le persone di buona volontà di unirci al coraggio del Papa condividendo la sua seguente riflessione pacata e vibrante sugli umili e gli ultimi. In questa egli ci chiede di aprire gli occhi in generale su tutte le piaghe dell’umanità: “i nostri fratelli uccisi, bruciati vivi, sgozzati, decapitati con le spade barbariche e con il silenzio vigliacco”; “i volti dei bambini, delle donne e delle persone, sfiniti e impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano che la morte e i tanti Pilati con le mani lavate”; i fondamentalismi” e il terrorismo di “quanti profanano il nome di Dio e lo utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze”, “i venditori di armi”, l’insaziabile cimitero del Mediterraneo e dell’Ego divenuto “immagine della nostra coscienza insensibile e narcotizzata”.
La mia convinzione è che gli umili della storia sono quelli che ci indicano la strada giusta, non a caso A. Manzoni sceglie gli umili come protagonisti del suo famoso romanzo “I Promessi Sposi”. Bisogna però convenire che quando gli umili sono anche ultimi le cose si complicano.
Gli umili sono coloro i quali accettano la propria condizione di miseria e di sofferenza nella misura in cui essa li rende più simili a Cristo che apre loro il regno dei cieli. Quella degli umili non è una categoria economico-sociale, ma etico-religiosa: gli umili sono i “poveri di spirito” di cui parla il Vangelo.
Bisogna schierarsi con chi crede che nel sociale le cose possano cambiare, che gli umili possano essere sottratti al giogo dei potenti e non essere eternamente ultimi, che si possa operare un cambiamento, che vi possa essere una pacifica rivoluzione come quella condotta da G. Scorzafave con questo libro. Dunque c’è bisogno di questa presa di coscienza e riconoscere nell’altro il fratello.
Ma quale è la situazione degli ultimi in questi primi ventidue anni del XXI secolo in Italia e quindi a Corigliano?
A quanto pare la strada da percorrere sembra presentare insidie su cui meditare. Lo Stato sta facendo la sua parte aiutando gli ultimi col reddito di cittadinanza, ma mi pare che non si riesca ancora a creare lavoro “vero”, “sano”, molti sono gli sfruttati nel campo dell’agricoltura. I nostri giovani diplomati e laureati vengono accontentati con stages e tirocini, che mi sembrano una moderna forma di sfruttamento, o con lavori sottopagati. Gli operai hanno bisogno di essere meglio tutelati principalmente al fine di evitare infortuni e morti sul posto di lavoro.
Avviandomi alla conclusione di questa mia presentazione devo riconoscere che questo libro-documento di Giovanni Scorzafave offre una coinvolgente ed interessante lettura sul Novecento degli umili e degli ultimi a Corigliano. L’autore tocca temi di grande valore sotto il profilo sociale e umano. Per esempio narra di adulti ai quale a suo tempo è stata negata l’infanzia, di una città che non sempre ha capito i bisogni dei suoi cittadini svantaggiati e verso i quali l’approccio è stato lo scherno, ma racconta anche di cittadini umili che con coraggio e capacità hanno saputo inventarsi un lavoro onesto e vivere e far vivere le loro famiglie con dignità. Non mancano esempi di umili che hanno saputo tenere lontano dalla loro vita l’egoismo e l’ingordigia, la superbia e la superstizione.
Sicuramente questo libro vuole spingere il lettore verso l’ascolto dell’altro e a porre la sua attenzione sui più deboli e sui defraudati.
L’autore invoca più volte gesti concreti di cristiana fratellanza e non atteggiamenti in cui domina la superstizione. Sono perfettamente d’accordo con lui.
Rinaldo Longo

RUMINICHIELLI ’I TRENTATRERANNI
(Domenico Montillo)
Domenico Montillo,[1] noto ai più come Ruminichielli ’i trentatreranni, era affetto sin dalla nascita da nanismo primordiale. Per questo suo deficit, nell’accrescimento somatico delle strutture anatomiche del corpo, viveva, quasi sempre, ai margini della società con severe e draconiane restrizioni.
Benvoluto da molti e schernito da pochi, per poter vivere, o meglio sopravvivere, ogni giorno era costretto ad adattarsi ai frenetici ritmi di una società poco solidale e discriminatoria, per cui cercava di cogliere ogni opportunità di “lavoro”. O forse nessuna. Viveva la sua vita con piccoli espedienti, affidandosi spesso all’indulgenza di quelle famiglie dagli animi nobili, che dimostravano nei suoi confronti comprensione e solidarietà. Erano proprio queste che in cambio di qualche commissione, come quella di fargli riempire di acqua piccole vùmmule (recipienti di terracotta) presso le fontanine pubbliche della città, gli offrivano un piatto caldo, un pezzo di pane con companatico (quattro olive e un pezzettino di formaggio fresco o stagionato) e un immancabile e affettuoso… sorriso.
Altre volte, invece, si affidava all’umanità di qualche generoso bottegaio, che gli assegnava dei semplici compiti adeguati al suo stato fisico di eterno bambino, come quello di consegnare a casa di qualche particolare cliente pochi e leggeri prodotti alimentari. Il mondo ’i Ruminichielli era questo, piccolo come lui.
Nella metà degli anni ’40 del secolo scorso, veniva accolto con grande umanità presso l’Ospizio di Mendicità e Vecchiaia, noto col nome “Cor Bonum”, ubicato in alcuni locali del pianoterra del Convento dei Minimi di San Francesco di Paola.
Si trattava di una vera casa famiglia, creata nel 1944, con grande spirito caritatevole, da uno degli uomini più nobili della nostra città, nonché un maestro di scuola e di vita, che stette sempre dalla parte dei più bisognosi: Alessandro de Rosis, noto a tutti come don Lisanni.
Lo ricordo con particolare affetto e grande stima, senza mai dimenticare quel suo modo di salutarmi quando mi incontrava: “guè!”. Quanta tenerezza in quelle tre semplici lettere! Erano tre lettere che annientavano la differenza tra lui, uomo generoso e maestro carismatico, e me, appena un ragazzino.[2]
Dopo questa mia breve e doverosa riflessione, ritorno al tema.
In questa accogliente casa, “Cor Bonum”, Ruminichielli, all’apparenza timido e tranquillo, diventava a volte inquieto e birbantello, dimostrando sofferenza per il suo stato fisico, ma soprattutto per la mancanza di soddisfazioni di quei bisogni emotivi ed affettivi che gli erano mancati sin da quando aveva aperto i suoi piccoli occhi al mondo.
Forse proprio per questo motivo era in eterno conflitto con i “vecchietti” dell’Ospizio. In particolare, derideva con gesti, che preferisco non riportare (perché da censura), Battista Montalto, uomo bonario e tollerante, noto come Battisa ’u sacristeni oppure come Battist’i ru Primiceriji, perché sagrestano della chiesa di San Giacomo Maggiore, dove celebrava la messa il Primicerio, Monsignor Antonio Colosimo.
Questo atteggiamento ’i Ruminichielli era anche una forma di reazione a tutti gli insulti che, a sua volta, subiva girovagando per le stradine della città, quando sfuggiva alla stretta sorveglianza del padre religioso Michele Serpe.
Infatti, spesso doveva subire le tracotanze di alcuni monelli di strada che, per molestia, gli prendevano, lanciandolo in aria, il suo piccolo e misero copricapo, una specie di baschetto, che gli serviva per proteggersi d’inverno dal freddo e d’estate dal caldo; altre volte, invece, addirittura, gli rubavano quei pochi spiccioli, che teneva avvolti e stretti in un fazzolettino di stoffa, attorcigliato con mille nodi, che teneva nelle minuscole tasche del suo pantalone o all’interno della sua giacchettina.
Erano dei veri mascalzoncelli, che si divertivano a prenderlo in giro per il particolare stato fisico; si trattava di una forma di vero bullismo.
A dire il vero, però, c’erano anche delle persone che gli volevano molto bene; lo accoglievano con autentica simpatia e con affetto incredibile, regalandogli cinque minuti di serenità. A volte anche di più.
A proposito di queste ultime persone devo ricordare che Ruminichielli aveva l’abitudine quando trovava, a pianoterra di un fabbricato, una porta aperta di una casa (e in quei tempi erano numerose) di considerarla sua, cioè quella che gli era sempre mancata sin da quando era un bambino, per cui si intrufolava dentro senza crearsi alcun tipo di problema. Si sedeva, in tutta comodità, su qualche seggiolina, che immancabilmente trovava sempre, e con le braccia conserte restava immobile come una statuina di cera fino all’arrivo di qualcuno.
La presenza dell’inatteso ospite sorprendeva la padrona di casa, che con un finto (e divertito) tono di rimprovero diceva: «… ma tu chi ci fè cchè?» (ma tu cosa fai qui?). Egli, per niente intimorito, non si scomponeva affatto, anzi, al contrario, con un’espressione ironica e un po’ giocosa, sostenuta da un eloquente e tenero sorrisetto, rispondeva con la solita frase imparata a memoria: «ma runa ’na cosicella» (mi dai una piccola cosa).
La "gradita" visita si concludeva, quasi sempre, con un piccolo dono da parte della padrona di casa: un pezzettino di pane, nu stuocchicielli ’i ssazizza (un minuzzolo di salciccia), qualche monetina di poco valore o qualche oggettino religioso, come le figurine o le medagliette dei santi, che Ruminichielli collezionava con amore e devozione.
Felice e contento per l’accoglienza e, soprattutto, per i doni ricevuti, andava via, ringraziando con la frase che soleva ripetere in molte occasioni: «ca vò steri bbona» (spero che tu stia bene), mentre riponeva le monetine nel suo piccolo “salvadanaio”, un fazzolettino stropicciato e macchiato di tutto, che annodava strettamente, e le figurine in una tasca della sua giacchettina di lana.
Poi avvicinava il pane alla bocca e cominciava a mangiarlo, felice come un bambino a cui avevano regalato un gradito e gustoso dolcetto, prima di trovare un altro uscio dove sedersi.
Così, ripeteva in altre case il rito dell’ospite inatteso fino a quando non sentiva i dodici rintocchi delle campane della chiesa di San Francesco, che gli ricordavano che era giunta l’ora di fare rientro.
Qui, all’Ospizio di Mendicità, sistemava con particolare attenzione in un posticino nascosto, ma che conoscevano bene tutti, le monetine, i santini e quelle poche briciole di pane che non era riuscito ancora a mandar giù.
Un altro aspetto singolare, che riguardava quest’uomo per la sua statura fortemente ridotta, era quello di essere considerato di buon augurio da molte persone; un vero folletto venuto chissà da quale bosco fatato.
Le mamme, quando lo vedevano nei pressi delle loro abitazioni, con la scusa di regalargli pochi spiccioli, lo chiamavano per una foto ricordo coi loro bambini. Ruminichielli non si sottraeva a questa richiesta, anzi, ne era particolarmente felice, perché per lui si presentava un’occasione per rendere felici quei bambini alti come lui e, soprattutto, le sue piccole tasche con qualche monetina di alluminio-magnesio con l’immagine del delfino. [3]
Prima della foto, però, pretendeva, senza se e senza ma, il regalino promesso; non era mica scemo!
A tale proposito si racconta che un giorno una mamma poco sensibile e irriguardosa, dopo una foto ricordo con il nostro ometto e i suoi figli, non abbia mantenuto la promessa del regalo, pensando di farla franca.
La signora aveva sbagliato i conti, perché l’oste, in questo caso l’eterno bambino, le presentava subito e in maniera del tutto singolare il conto: senza scomporsi, entrava in casa, si sedeva con l’intenzione di non andare via se non dopo aver ricevuto il giusto compenso promesso, una semplice monetina con due spighe di grano e (dietro) un aratro,[4] ma era il giusto premio per la sua “prestazione professionale”.
Ruminichielli, però, non era solo questo. La sua fantasia, a volte, spaziava in orizzonti più ampi e ambiziosi, dove la sua creatività diventava uno strumento di dialogo, quasi un’opportunità per sconfiggere la solitudine.
Infatti, ricordandosi della professione di banditore del nonno paterno, Francesco (classe 1819),[5] qualche volta svolgeva questo particolare compito di proclamatore da fare concorrenza a “Gigi” (Luigi Guarnieri), il banditore per antonomasia di Corigliano, che a suon di squilli di tromba annunciava in quegli anni per le strade principali della città i messaggi del giorno.
Infatti, non di rado, alcuni importanti nostri cantinieri, per pochi spiccioli, gli davano l’incarico di divulgare all’intera cittadinanza la notizia della dell’arrivo del loro buon vino novello.
Ruminichielli, solo dopo aver ricevuto il simbolico compenso in denaro, quasi sempre un paio di monetine da 10 lire, saliva, non senza difficoltà, i quattro gradini che conducevano all’astrachielli ’i ra varbarija ’i mastro Pippini ’i Marinari (pianerottolo antistante il salone di mastro Giuseppe Servidio, soprannominato “Marinari”).
Appoggiandosi al tubo orizzontale in ferro della ringhiera, con la sua caratteristica vocina, così si rivolgeva alla gente che stazionava all’Acquanova: «si vi vulìti cunzeri ’u stòmachi, jeti a ra cantina ’i massa Grigorio ’i Cupielli c’ha ’ntrivillèti ’u vini nuovi, fujiti, genti, … fujiti» (se vi volete aggiustare lo stomaco, andate alla cantina di Gregorio Caldeo perché ha iniziato a spillare il vino novello, accorrete, gente… accorrete).
Dopo una pausa di circa una decina di secondi, probabilmente per riprendere fiato, come se avesse pronunciato chissà quale lungo discorso nella sua lingua madre, ripeteva l’annuncio per altre due volte.
Be’, direte voi, il lavoro era finito. No, signori. Il bando non finiva qui. Tutt’altro. Restava ancora la parte pittoresca, quella particolarmente spettacolare attesa dalle numerose persone presenti all’Acquanova. Ruminichielli, il “banditore in erba”, dotato anche di grande spirito e ironia, concludeva il suo intervento con l’immancabile nasc(i)hièta, cioè una particolare tirata di fiato rumorosa col naso, un caratteristico suono nasale simile ad una spernacchiata o meglio ancora ad un simpatico grugnito.
A questo punto la piazza esplodeva in un coro di giubilo, di ammirazione e di risate. L’applauso fragoroso di tutti i presenti era talmente forte da richiamare, per la grande curiosità, altre persone all’Acquanova.
Sembrava che si stesse svolgendo un comizio di qualche illustre politico di allora. Quella “simpatica” pernacchia era, però, solo la voce della sua “trombetta naturale” che voleva dire che il bando era terminato.
Unanime era il tributo di affetto ad un uomo, il cui unico “torto” era quello di essere nato con un fisico particolare, costretto a guardare uomini e donne sempre dal basso.
Così, Ruminichielli, uomo emarginato e dileggiato da alcune persone senza scrupoli, viveva finalmente i suoi minuti di gloria nella piazza più importante della città, all’Acquanova.
Anche se in una veste goliardica e satirica, era il giusto riscatto di una vita vissuta, in piena solitudine, sulla riva del mare dei pregiudizi e dell’ignoranza, un’immensa distesa di sabbia dal colore nero, molto intenso, quello che caratterizza l’odio per la diversità.
Finalmente quel piccolo pianerottolo, dove eminenti personaggi pronunciavano le famose orazioni funebri in memoria di defunti illustri, aveva dato l’opportunità a Domenico Montillo - così adesso mi piace chiamarlo – di vedere uomini e donne da una nuova prospettiva, quella di guardarli finalmente dall’alto, e non più dal basso.
Negli anni ’60, per vari motivi, l’Ospizio fu costretto a limitare la propria attività. Rimasero solo in pochi, quelli più anziani. Tra questi ultimi non poteva mancare l’irriducibile Ruminichielli ’i trentatreranni.
Poi, come tanti altri personaggi di allora a me particolarmente cari, anche il Montillo scomparve dalla mia vista, ma non dalla mia memoria, che, sebbene dalle capacità limitate e leggermente smagnetizzata dal tempo, conserva ancora un affettuoso ricordo, che continuo a tenere dentro di me e a raccontare con umiltà e semplicità, affinché le nuove generazioni sappiano che gli uomini sono tutti uguali e non si misurano in centimetri, ma solo in base alla loro dignità, onestà e rispetto verso il Prossimo.
Solo così possiamo sperare in un mondo migliore, dove il bene finalmente possa prevalere sul male.
Oggi, sono certo che il nostro personaggio dove attualmente vive, nella città dei Giusti, sotto la stretta sorveglianza non più di padre Michele Serpe, ma del Signore, non continuerà più a prendere simpaticamente in giro Battisti ’u sacristeni.
Gli starà accanto con affetto e tenerezza, come starà accanto con altrettanta amorevolezza a tutti i suoi compagni dell’Ospizio: Carolina B.; Angelo S. ; Tommaso P. ; Isola D. ; Antonio P. ; Vincenzo G. ; Carmela T. ; Agata M. ; Antonio D.C. ; Angelo M. ; Francesco S. ; Marianna B. ; Cristina T. ; Maria Rosa S. ; Giorgio S. ; Filomena G. ; Domenico P. ; Vincenzo G. ; Lucia Z. ; Antonio T. ; Salvatore L. ; Rosa S. ; Leonardo S. ; Maria A. ; Maria Carmela Z. ; Giovanni O.
A Ruminichielli e ai suoi cari compagni di merenda, orgoglioso di essere stato un loro concittadino, rivolgo, tramite queste poche righe, un sincero e rispettoso ringraziamento per avermi insegnato con la loro presenza quei principi di rispetto verso le persone più fragili, ma nel contempo forti della dignità e dell’onestà che li hanno sempre contraddistinti durante la loro permanenza in questo misero mondo.
Come, pure, ringrazio, ancora una volta, uno dei membri della famiglia dei baroni de Rosis, don Lisanni, per aver scritto, nella metà del Novecento, una delle più belle pagine per la nostra città. Non solo, ma anche per avermi insegnato a stare sempre, e comunque, dalla parte di quelli che, purtroppo, ancora in questo terzo millennio vengono definiti “ultimi”, ma “ultimi” non sono, perché non sono secondi a nessuno.
[1] Domenico Montillo, all’anagrafe anche Vincenzo, figlio di Antonio (classe 1848) e di Marianna Casciaro, era nato a Corigliano, in via Capalbo, il 14 ottobre del 1896. Cessava di vivere il 9 aprile del 1974 a Cassano All’Ionio. Probabilmente il soprannome gli era stato dato da qualcuno alla fine degli anni ‘30, quando effettivamente aveva 33 anni. Ecco cosa, invece, mi scriveva tempo fa il caro amico Gerardo Bonifiglio sulla questione del soprannome del Montillo: Resta un mistero quell’appellativo che se giustificava il diminutivo del nome, che come abbiamo visto si confaceva alle caratteristiche fisiche del personaggio, non spiegava il perché di quei “trentatré anni” che tali restarono per tutto il corso della sua vita. Né siamo in grado di svelare quando e chi glielo assegnò. Se vogliamo dare retta all’importanza dei numeri in molti contesti, non solo esoterici, il numero 33 è un numero definito “maestro” e “fortunato” già dai tempi dello storico Flavio Giuseppe, possiamo quindi dire che probabilmente l’appellativo di “33 anni” fu dato al nostro da qualche “intellettuale”. O se vogliamo, non è da escludere che il numero faccia riferimento all’età di Gesù che come sappiamo anche lui, per altri versi, fu fatto oggetto di vessazioni, insultato e schernito
[2] Alessandro de Rosis (18-3-1919 / 4-10-1970) svolse una funzione importante nella vita culturale e sociale della nostra città negli anni che seguirono la fine della Seconda Guerra Mondiale. Diplomatosi come insegnante nel 1939, sposò il 28 febbraio del 1942 la maestra Grazia Aceto, una donna dalle straordinarie virtù, che gli diede otto splendidi figli (Fonte: Il Serratore n.2)
[3] Erano le 5 lire emesse nei primissimi anni ’50 del secolo scorso
[4] Le monetine con le due spighe di grano e l’aratro furono coniate per la prima volta nel 1951
[5] Anche uno dei fratelli del padre, Giovanni (1851 - 1908), eserciterà a Corigliano la professione di banditore fino ai suoi ultimi giorni di vita
Altri Personaggi

ZIO CASSAVIA
Uno straordinario affabulatore, come zia Filomena, di cui vi parlerò
prossimamente, era anche zio Cassavia. Noi tutti lo chiamavamo così, ma avremmo dovuto chiamarlo zio Natale, perché il suo nome era Natale e non Cassavia, ch’era il suo cognome. Parlare di lui,
personaggio “mitico” della mia fanciullezza e adolescenza, per me è sempre un invito a nozze. Anziano, di bassa statura, molto magro, volto scavato, rugoso, occhi profondi, fiammeggianti, arcani,
un bel paio di baffi, incolti e alquanto ingialliti per via del fumo (fumava ininterrottamente, ora una vecchia pipa di creta, ora dei mozziconi di sigaro, che a volte masticava come fossero
chewing-gum) e mani che conoscevano la durezza della vita.
Zio Cassavia abitava in via Addolorata, 3, sotto il Castello. Era
sposato con una donna un po’ più giovane di lui e aveva già diversi figli e nipoti. Aveva fatto la “Grande Guerra” ed era cavaliere di Vittorio Veneto, di cui andava fiero. Era, come lui stesso
amava dire “ un umile, fedelissimo servitore dei baroni Compagna”. Curava (e come la curava! ) la villa del Castello, di cui era anche vigilissimo guardiano. Una villa che sembrava un piccolo
Eden. Vi era una varietà incredibile di piante ornamentali e da frutto. Ricordo, con un pizzico di nostalgia velata di malinconia, quando zio Cassavia chiamava mia madre e, attraverso il muro di
cinta della villa, le porgeva un panierino di nespole appena raccolte: un sapore indescrivibile!
Sul nostro antico, maestoso Castello, si raccontavano fatti, storielle
curiose che andavano facilmente ben oltre la realtà, racconti cioè molto fantasiosi, ma che affascinavano, allora, chiunque avesse l’occasione di ascoltarli. Anche a zio Cassavia piaceva molto
raccontare queste storielle e, quando le raccontava, aggiungeva sempre qualcosa di suo. Una volta mi parlò di un antico specchio “magico” che denudava chiunque vi si specchiasse, ed io, credulone
(ero ancora un ragazzino), ero convinto che fosse tutto vero. E sempre più spesso, pendevo dalle sue labbra, specie quando raccontava, anche con gesti e mimica facciale adeguati al contesto,
fatti di briganti, di fantasmi e lupi mannari. Ora i fantasmi non ci sono più, scomparsi ormai da tempo anche i lupi mannari, ma il “fantasma” di zio Cassavia è sempre lì, all’ombra del
Castello…
(Ringrazio sentitamente l'amico vigile Giuseppe Berardi
per la "storica" foto, che ritrae zio Cassavia
all'interno
dell'ingresso del nostro Castello
Ducale.)
Pasquale Bennardo
I Miei Sogni
Il Riscatto Eterno

Questi personaggi, a me particolarmente cari, li ho rappresentati come li sognai un po' di anni fa. I sogni non si spiegano. In ogni caso, se esiste - veramente - il Paradiso, sono certo che è proprio qui l'attuale residenza di queste umili persone.
 LA "MIA" CITTÀ: CORIGLIANO CALABRO
LA "MIA" CITTÀ: CORIGLIANO CALABRO