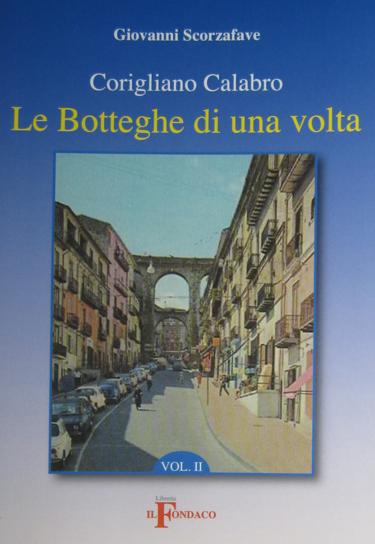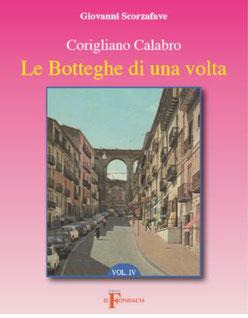Correva l'anno 1868
16 maggio 1868: il rapimento di Alessandro de Rosis ad opera del brigante Domenico Straface, detto Palma
Dal diario di Alessandro de Rosis Morgia sui suoi trentasei giorni coi briganti
Giornata prima (rapimento)
La mattina del 16 Maggio 1868 fu bussato alla porta di mia casa, ed un uomo sui quarant’anni, con una foresta di capelli e con folta barba che gli nascondeva intieramente le gote le labbra e il mento, si fece introdurre nelle mie stanze chiedendomi un soccorso, dicendomi d’aver figli digiuni e non poter trovare da più tempo lavoro.
I suoi laceri panni imbrattati di calce, ed il suo volto squallido e dimesso il dicevano per un operaio avvilito sotto il peso della miseria. Ma l’occhio di Lavator avrebbe osservato in lui un assassino, un’omicida.
Donde sei tu? Gli domandai con certa curiosa premura.
Ed egli di Rossano signore, e volea più dire ma io per finirla gli diedi una moneta di cinque lire in argento, indicandogli la porta d’uscita.
Grazie della carità e possa il Signore rimunerarvene, io me ne vado e vi bacio la mano. E il furbo col cappello sotto il braccio infilò la prima porta, e quindi fu in una anticamera fingendo smarrirsi errava per la porta che non sapeva trovare mi fu d’uopo alzarmi ed aprirgliela io stesso; ed osservatolo meglio mi avvidi che il suo occhio avea alcunché di falso come quello del gatto, e di burbero come quello della tigre, e diffidai fortemente di lui. Balbettò alcune parole di scusa e disparì per le scale. Dissi allora io fra me, quest0uomo non deve essere muratore, quantunque tali il dicono le sue apparenze, quest’uomo mi fa paura. Essendo in tale pensiero con una curiosità inspirata da timore, mi affacciai su una terrazza sporgente sulla spianata di mia casa per osservare qual via tenesse e vidi che postosi a seder su un poggiuolo di pietra, si mise a pulirsi di quei schizzi di calce che gli lordavano il vestito, senza badare ai passanti; poneva in quella bisogna l’attenzione del migliore uomo del mondo.
Ma non erano ancora scorse due ore che una seconda scampanellata alla porta fece correre un famiglio ad aprire, e mi vidi dinanzi un altro muratore. Questo poi sì che aveva la fisonomia ben singolare. Era costui una specie di gigante con in testa un cappello a larghe tese tirato a sghembo da cui scappavano alcuni cernecchi di capelli ruvidi e tesi come setole di cinghiale, occhi selvaggi e trucolenti, mani grosse e abbronzate, e sotto le sue labbra maliziose e sottili vedeasi una fila di denti acuminati e forti come quelli del lupo cerviero. È inutile aggiungere che il suo vestito perfettamente simile a quello del suo compagno il diceva operaio muratore. Ma se quegli che mi aveva ispirato certo sfiducia, questo pel terrore io non potevo sostenere quei suoi sguardi ferini, quantunque destramente velati da un’umiltà ipocrita, essi mi paralizzavano ed esercitavano su di me la funesta attrazione dell’occhio della serpe sull’incauto agnello.
Come mel vidi dinanzi feci un moto di sorpresa perché di già sentiva per lui senza conoscerlo, uno di quegli odi istintivi che non si possono spiegare dalla filosofia, ma che esistono e si sviluppano nel gran teatro della natura. Se l’uomo potesse farsi addentro a certi misteri non sarebbe tante volte bersaglio della sventura.
E che desiderate? Gli dissi affettando sicurtà ed energia, e nell’aria di un uomo che ha pietà. Niente Signore; rispose con melata voce; io non son venuto per elemosina, come ha fatto il mio compagno, ma a pregarvi per dare a me ed a lui del lavoro.
Buon uomo, io per ora non posso darvi del lavoro, ma cercherò procurarvelo, però accettate questo piccolo sussidio, dandogli un’altra moneta di lire cinque e l’accomiatai. Un’altra parola, di grazia eccellenza replicò a dire, leggete questa mia supplica, ve ne prego. Ma che altro volete, gli dissi, andate via!
Niente, nulla Signore, solo che leggiate questa mia carta.
Che supplica, che carta mi andate contando, soggiunsi con moto d’impazienza. Andate via in pace amico mio io non ho voglia di leggerla. E gli volsi le spalle lasciandolo là con la carta spiegata in mano, ed in alterchi col famiglio il quale lo accomiatava brontolando giù per le scale, per chiudere definitivamente il portone, onde non essere più vessati di simili operai muratori. Io però mi sentii compreso da una misteriosa inquietezza, mi assalì una profonda malinconia che mi tenne tutta la giornata uggioso e taciturno, e tanto più m’opprimeva il cuore perché non ne sapevo indovinare la cagione.
Nel circondario di Rossano scorrazzava la comitiva del Capobanda Domenico Straface Palma, la quale forte di tredici uomini, ricattava persone, taglieggiava famiglie, massacrava barbaramente uomini e bestie, lasciando da per tutto la funesta impronta della sua terribile dominazione. Principal teatro delle sue scorrerie era il territorio del mio paese Corigliano Calabro, ov’ella aveva gettato la desolazione e il terrore tenendolo per otto anni stretto in una cerchia di ferro e di fiamme.
Questo tremendo flagello avrebbe dovuto darmi un poco a pensare, e farmi indovinare la vera intenzione dei due visitatori di quella mattina. Ma non ci pensai gran fatto. D’altronde non ero io in mia casa? Ed essa non era situata quasi al centro dell’abitato il quale non può dirsi una bicocca, ma una grossa borgata di circa 16.000 abitanti? Non vi erano forse guardie Nazionali, Carabinieri, due battaglioni di bersaglieri, ed uno squadrone di cavalleria pronti a tutelare la vita e la robba dei cittadini? Eppure la porta della mia casa avrebbe dovuto da quella mattina murarsi, ed io con tutti i miei serrarmi come in una prigione dalle mura di bronzo, perché eravamo per la nostra modesta fortuna, mirati dai manutengoli del Palma; e nei registri briganteschi segnati nigro lapillo.
Stetti adunque tutto quel giorno in balia di una tristezza indicibile, ero malinconico e inquieto, e per uscire un poco di quello stato opprimente verso le 7 p.m. sortii di casa. Dopo aver salutato mia madre, varcata appena la soglia, i miei occhi andarono istintivamente al poggiuolo ove la mattina si era seduto il muratore, e lo vidi deserto. Solo alcuni monelli di divertivano accanto a quel poggiuolo a tirar delle sassate alle rondini che svolazzavano cinguettando per l’aria. E le donne del vicinato erano intente ad allestire il parco desinare pe’ loro mariti di ritorno dalla campagna. E già incominciavano ad arrivare frotte di villani cacciandosi innanzi i loro asinelli carichi di fasci di legna e di erba; e lontano lontano udivasi l’allegro canto delle donne che lavoravano nelle fabbriche di liquirizia, con cui salutavano il tramonto di un lungo giorno di maggio.
Quest’ordinario andamento di cose mi fece lasciare ogni sospetto, non però quella cupa tetraggine alla quale ero in preda fin dalla mattina, e così indisposto e preoccupato mi avviai verso la pubblica piazza. Ma non avevo fatto che pochi passi quando vidi l’uomo della limosina sbucare da un vicoletto adiacente alla strada maestra, e facendo lo stordito mi passò a panni, e mi salutò, cavandosi rispettosamente il cappello. Resi il saluto e continuai il mio cammino. Ma qual fu la mia sorpresa quando a pochi passi distanti vidi quel bestiale omaccio del suo compagno sdraiato a terra, e col capo richinato sur una pietra in sembianze di quei miserabili figli dell’ozio e della miseria, che si pongono al sole per uccidere, com’essi dicono, il tempo? Mi si rinnovarono tutte le paure e la trepidazione della mattina e stetti lì lì per tornare a casa. Oh se l’avessi fatto… Ma io ero uscito per distrarmi, e mi avanzai verso la piazza insino al caffè.
Un caffè in paese è per gli spensierati un’oasi nel deserto, un piccolo mondo nel gran mondo, una repubblica che tocca l’idea del progresso in mezzo all’universale dispotismo, esso è il posto d’unione; colà il Sindaco e il cittadino, il percettore e i suoi contribuenti, il Pretore e gli avvocati, il Conciliatore e le sue parti siedono all’istesso posto attorno al medesimo tavoliere. Ognuno parla come la sente, vuota il sacco e ne cava la novità della giornata buone e mali che siano, si parla di pace e di guerra, si rompono alleanze, e si stringono trattati. Quando tu sei tra loro, ti pare di essere in un concilio di re. Battaglie vinte e perdute, capitani premiati e puniti, province e regni dati e tolti sono la materia principale dei discorsi e ti senti tra loro un cicalio permanente, un ciaramellare continuo intorno alle più sperticate cose, e a misura che cresce l’interesse della materia in discussione tanto più rumoreggia un frastuono, sicché te ne esci con la testa intronata e piena delle più bislacche cose del mondo. Io ci solevo andare per vedere qualche amico, e dopo un’oretta passata allegramente me ne ritornavo a casa, a tener compagnia alla mia diletta madre, accompagnato sempre però da qualche mio famiglio.
Così pure quella sera dopo che mi ci trattenni fino ad un’ora di notte, senza avere per nulla messo giù quella malinconia che mi opprimeva ne uscii accompagnato da due miei guardiani uno a nome Antonio Tortorelli, e l’altro Giuseppe Sapia, che stava per tradirmi.
Siccome in quel giorno il cielo era stato del più limpido azzurro ed illuminato del più splendido sole di Maggio succedé ad esso una di quelle sere che riempivano l’animo di dolcissime e poetiche emozioni, e l’aer tiepido e sereno impregnato da balsamici effusi primaverili invitava a godere le misteriose delizie della stagione, in cui per le fibre della natura freme un alito di vita novella; ma di repente il cielo si abbuia, la luna s’ascende fra le nuvole, forse per non guardare tanta scelleranza, una fitta nebbia succede al bel sereno.
Io però me ne andavo per la mia strada come un uomo che pensi a sventura, come se l’anima fosse presaga della tremenda disgrazia che dovea tenermi nel più bel fiore della mia gioventù. Ah meglio meglio se non fossi mai nato, o se uscito appena dal seno materno fossi passato alla tomba.
Giunto a un trar di mano dalla mia casa, alla fioca luce di un lampione vidi Sapia, il quale mi precedeva, andare a passi indecisi, talvolta anco fermarsi, strofinarsi colla mano la fronte come per allontanarne una nube, o un pensiero molesto, e riflettere come uomo che s’accinga ad un passo pericoloso. Io non potevo bene affisarlo, perché mi volgeva le spalle, e poi era anco di notte, pure essendosi un po’ volto indietro, forse per osservare se io e Tortorelli le seguivamo, mi parea vedere il suo volto soffuso di quel glaciale colore onde son dipinti quei famosi scellerati, cui la fantasia del Divino Poeta immaginò tuffati nel cerchio di Giuda, in un lago di lacrime aggelato. Quel suo volto, quel suo andare incerto e sospetto fecemi sostenere il passo, lo chiamai e gli dissi. Ohimè, Sapia, il tuo volto è di un pallore di morte, i tuoi passi sono indecisi, a che pensi adunque! Hai tu nulla forse veduto? Voltiamo indietro!
Niente! Rispose con risoluta voce, io non veggo nulla! Ed abbassò gli occhi avviandosi verso il portone, in cui sparì come un’ombra. Tortorelli mi stava a panni, e siccome occorreva fare altri pochi passi per entrare in mia casa, mi affrettai a guadagnare il piccolo spazio per raggiungere anche io il portone, ove mi credea sicuro. Ed ecco che appena ci avea messo piede mi vidi inopinatamente di fronte l’uomo dell’elemosina, il muratore che s’avanzava contro di me e Tortorelli. Come lo vidi alzai un alto grido, e rinculai stendendo la mano in avanti come per iscongiurare uno spettro nunzio di morte. Ma l’assassino s’avanzava sempre ed io per evitarlo mi volsi indietro volendo fuggire verso la piazza. Quando tutto ad un tratto due braccia mi cingono per di dietro la vita e mi tengono stretto come in una morsa. Mi provo a gridare all’accorri uomo! Agl’assassini ai briganti! Ma queste parole che mi vennero fuori dalla strozza come il rantolo di chi viene soffocato, non erano udite dai miei vicini! Che come statue mi guardavano dalle loro finestre! Raccolsi allora tutte le forze per svincolarmi dalla stetta di quell’uomo terribile, ma ei mi fermò come una rupe stringendomi contro il petto, e mi aggavignava colle sue braccia come il serpente boa aggavigna, nel deserto, il cavallo selvatico per istrozzarlo, e mi credetti perduto. La sua nigra barba mi sfiorava il collo e le gote; e rabbrividiva, il su alito di assassino mi entrava nelle narici, e mi soffocava, e di tratto in tratto mi faceva colare nelle orecchie le parole: zitto o sei morto, arrenditi, non facciamo manovre! le quali mi scendevano al cuore come gocce di pianto bollente. Ma non avea ancora osservato chi fosse il mio manigoldo, e perciò torsi un poco il collo indietro per rimirarlo in faccia, e vidi che mi trovava fra le braccia del muratore, e fra quelle del Sapia, che fingeva di volermi liberare da quella stretta, dicendo liberate il mio Signore, mentre lui più di quello mi stringeva. Mestamente lo guardai in volto, e vidi che i suoi occhi sfolgoravano come quelli della tigre. Provai allora un’amarezza, un dolore da non comprendersi vedendo Sapia ch’era già passato tra i miei nemici, vedendomi così barbaramente tradito. E il misero Tortorelli assordava con le sue grida il cielo, e dibbatteasi fra le mani d’altro brigante. Pure cacciai novelle grida, le quali rimbombavano fra le interne volte di mia casa, e vi destarono l’allarme. Subitamente si spalancò un balcone, e udii le grida, il pianto, e le disperazioni della santa madre mia. Colle mani attaccate ai ferri del balcone, cola faccia atterrita, coi capelli scompigliati la derelitta gridava sui delenti-aiuto! Accorrete, salvate il figlio mio! E quelle grida stringenti infondendomi novello coraggio feci uno sforzo supremo per liberarmi, ed esclamai a madre! Ah infelice madre mia! In quella mi vidi assalito da altri due uomini neri come la notte i quali fecero la mossa di volermi caricare di peso sulle loro spalle e fuggire. E poi ne corsero altri due, sei persone in tutto le quali mi agguantarono furiosamente, e colla violenza del turbine mi trasportarono fuori dall’abitato. Io non avea ancora misurato tutta la gravezza della mia sventura, avea qualche speranza di poter essere alfine strappato dalle loro mani, ed ero perciò restio a seguirli.
Ma quei malfattori vedendo che si predeva tempo con fiere spinte ed urtoni cercavano farmi comprendere la necessità di dovere affrettare il passo, e poi senz’altro mi afferrarono per un piede, e giù per la dirupata strada Cerria, per luoghi ripidi e fangosi mi trascinarono come una cosa morta in fondo al vallone ove rumoreggia il torrente Coriglianeto.
Ohime! Quanto soffersi in quell’orrida notte, la mia testa batteva contro pietre, le mani e la faccia venivano graffiate dalle spine, le membra tutte peste e ammantate, quando si fece sosta vicino ai mulini io facevo orrore a me stesso. Avea le mani e la faccia insanguinante e lorde di fango, le ossa tutte indolenzite, e gli abiti schifosi e laceri, che mi pendeano a brandelli dalla persona. Ma io ero in mano dei briganti, il che vuol dire che la mia vita pendeva da un debol filo, che le sostanze di mia casa, erano a discrezione d’uomini che arrischiavano la vita per l’oro.
Allora sì che la mia sventura mi si appalesò in tutta la sua terribile realtà.
Pure non era questo il pensiero che stringeami, lontano da me, oltre di quel cupo vallone io avea lasciato fratelli, zii, ed una diletta zia, e poi la cara e santa persona di mia madre, la quale era in quell’atto forse tramortita o affranta dal dolore, e queste reminiscenze mi faceano la mente torta. Io mi vedevo sempre dinanzi agli occhi quel balcone spalancato, e nel suo vano disegnarsi l’ombra della mia veneranda madre, con la fronte sparsa di un pallore di morte, e lo schianto nell’anima, mi suonavano alle orecchie le grida dolenti che la costernata lanciava all’aria, acciò fosse accorso qualcuno a salvarmi, immaginava che la trambosciata e sofferente provasse tutti i dolori che può provare un cuore di madre, e a queste considerazioni mi si indirizzavano sulla fronte i capelli, e mi solcavano le guance lagrine brucianti. No che niuna madre al mondo soffra mai tanto! Quanto tu soffristi per la sorte del tuo infelice figlio. Ma non finivano qui le mie torture morali,
Considerando che essendomi dibattuto innanzi alla porta di mia casa per una mezz’ora contro i briganti, urlando, strepitando, chiedendo aiuto con voci ce avrebbero commosso le pietre, e che in tutto questo frattempo non era accorso nessuno nel luogo della scena funesta mi sentiva compreso da un dolore ineffabile. Eppure per liberarmi sarebbero bastate le grida di oca gente accorsa, gli strepiti di quattro donne, perché il brigante è sempre perseguitato dalla paura.
Vero è che ne volò all’istante l’infausta novella alla vicina caserma della Guardia Nazionale, ai Carabinieri, ed alla truppa acquartierata fuori l’abitato, ma il Capitano della Guardia nazionale Comandante in quella sera, con una avvedutezza degna veramente degli uomini di Plutarco, fece battere il tamburo acciò si fosse destato l’allarme nella popolazione, e lo scoraggiamento nei briganti. E quel tamburo cominciò a suonare con un fracasso del diavolo a suonare a raccolta.
Suona! – inculcava il Capitano al tamburino, con voce marziale, suona a raccolta, all’assemblea, batti la generale, acciò accorrano militi, uomini, popolo, donne giacché si deve dare caccia ai briganti-.
Non declino il nome di questo Capitano per non rinfocolare ire assopite. E subitamente quel benedetto tamburo incominciò a far sentire i suoi ta-ra-ta-pla infernali più che non fossero i tamburi di Austerliz.
I suoi rulli accelerati risuonavano continuamente, e ne rimbombavano i solitari valloni; i miei occhi si erano intronati, e nulla sapendo che tutto quell’ardore guerresco sarebbe andato a finire in una amara derisione (mandando dopo tre ore del mio ricatto 34 militi per contraria direzione) mi dava coraggio e cercava tener fermo onde non essere trascinato fuori dell’abitato. Io diceva tra me: Se accorre il il popolo! I militi prenderanno le armi assieme alla truppa regolare, presto ci raggiungeranno ed io sarò strappato alle vostre ugne briganti maledetti. Aspetta, aspetta, aspetta! E finalmente tace il tamburo. Or ora militi popolo e soldati si avvicinano e quatti quatti fra le ombre daranno la caccia ai briganti! allora io fuggirò, sì fuggirò. Poveraccio di me! Non si vide venire neppure una mosca, non scintillare una fiaccola. Tardi me ne avvidi senza dubbio ma pure non durai fatica a comprendere che quello era il soccorso di Pisa; e che per l’avarizia dei manutengoli miei concittadini i briganti non sarebbero stati per allora inseguiti!
Dopo 36 giorni, che per miracolo fui liberato, venni a sapere la cagione perché non accorse in tempo la Guardia Nazionale, e piansi sinceramente più sulla codardia e malvagità degl’uomini che sulla propria mia sventura. Ma non più una parola di queste cose, che farebbero onta e vituperio a me stesso dovendo parlare di degeneri figli della mia infelice patria, piena di manutengoli, di vili, di servi, e di liberti… e ripiglio il mesto racconto.
Dopo qualche tempo che uscii di quel doloroso stupore mi asciugai le lagrime e con miglior consiglio cominciai ad acconciarmi con la mia sventura. I sei briganti si erano messi a sedere sul greto del Coriglianeto per ripigliare nuova lena giacché sia pel travaglio che per la paura affannavano con una muta di caccia al cinghiale, e si asciugavano il sudore colle loro pezzuole, io pure me ne andava disteso sull’arena. Quando tutti a un tratto si alzarono, e presto, Signore, cominciate a battere i vostri tacchi perché si deve partire; disse il muratore del cappello a larghe tese, che poi conobbi chiamarsi Gioacchino Rango.
Ed io mi rizzai sulle tremanti ginocchia.
- Credo; soggiunse poscia il brigante, che da quest’ora in poi non farete più le strida di un fanciullo giurando! Che innanzi a quella vostra maledetta casa avete fatto un chiasso da destare un morto, sicché poco è mancato che non ci fosse venuto sopra un nugolo di quei vostri cicisbei di Guardia Nazionale. Ma nel fo per dire, vi trovavate fra buone mani, e per Cristo … solo io sarei bastato a far fronte.
- Se strilla gli metteremo il bavaglio, rispose un altro allora.
- Zitti! Non vi vuole bavaglio; soggiunse il Rango, rivolto a me continuò a dire.
- E poi vi contorcevate fra le mie braccia come una serpe, mi sembravate un’anguilla.
- Se tenterà di fuggire gli metteremo i ferri ai piedi; minacciò un altro.
- Zitti ho detto voi, tornò a dire il Rango; non ci vuole bavaglio né ferri; questo giovinotto è di ottima pasta mi ha fatto dare cinque di elemosina, e ci seguirà di buona voglia come un agnello domato col pane e col sale; ma non è vero signore? Ma voi non rispondete? Tenete a mente veh, che se vi verrà il maledetto ticchio di darvela a gambe sarete agguantato e legato mani e piedi e strascinato come una carogna, non so se mi spiego! –
A tutte queste minacce non risposi alcun motto, e mi contentai di far cadere su quell’uomo brutale uno sguardo di compassione, e d’infinito disprezzo.
– Animo coraggio andiamo; disse poi ai compagni; e cominciamo a salire. Allora cominciai a provare momenti assai dolorosi e crudeli. Siccome si andava per una collina coltivata ad ulivi, situata ad occidente dalla città; denominata Costa, a misura che si saliva si scoprivano montagne e marine pianure d’ulivi, e giardini deliziosi su cui batteva la luna. La città poi mi avea l’aspetto di un cimitero. Io vedea frastagliarsi nell’orizzonte i comignoli delle case, le croci dei campanili, e le torri di un antico castello (delicatamente imbiancato). E poiché poco di là lontana trovavasi la mia casa ritornavo col pensiero ai miei cari, alla desolata mia madre, e fermavami per isfogare in un sospiro l’amara ambascia dell’anima.
Continua! – diceva con rauca voce il rango – Che guardi? non vengono più, non possono venire più ad aiutarti: noi dobbiamo essere su quella punta, guarda – Ed accennava con la mano la cima della collina – Cammina o ti ammazzo la scapula col piatto della mia coltellaccia – mnacciava Pataracchio, l’altro brigante che mi stava dallato. Ed io mi affaticava a salire il mio calvario nel più cupo silenzio della notte. Ci volle una buona mezz’ora di faticosa salita per guadagnare l’altura, e quando si fece sosta io cedei alla stanchezza e mi lasciai cadere pesantemente per terra. Allora i sei briganti mi sedettero d’attorno disposti in cerchio, e si asciugavano il sudore dalla faccia e dal petto mormorando bestemmie parlate in nessuna lingua del mondo; quando s’udì un calpestio di più persone, e vennero alla nostra volta altri sette uomini armati fino ai denti. I loro volti erano foschi come la notte, i loro fucili ad armacollo brillavano al raggio della luna.
Dov’è? Me l’avete portato? – disse una voce simile all’urlo del lupo, uno dei sopraggiunti.
- Sissignore eccolo qua buttato a terra come un sacco di cenci, che né parla né si muove.
Io in quel momento mi raccomandava al padre dei tribolati e diceva: Esaudite, o Signore, la voce mia, colla quale V’invoco: abbiate misericordia di me ed esauditemi.
Dov’è? Dov’è disse l’uomo lupo, il quale non era altri che il famigerato Capobanda Domenico Straface Palma – Ah! Sei qui? Finalmente ci sei capitato! … sangue di un turco, tu mi costi un occhio del capo; ma finalmente sei in mio potere. Oh bella, morte ai Signori, ai nostri nemici e viva la compagnia! Esclamò agitando in aria il suo cappello. Morte ai Signori! E viva il Palma! esclamarono ad un tempo dodici uomini, agitando anch’essi in aria i loro cappelli.
– E viva tutti i nostri amici di Corigliano che si sono prestati! Rispose il Capo.
- E viva i buoni amici! Ad una voce dissero tutti.
– Io m’immagino – disse il Capobanda – che questo tisicuccio vi avrà fatto sudare sangue mettendo a rumore tutto il paese, perché parmi di avere inteso trimpellare un tamburo, non è verò?
- Sissignore, Capitano, un tamburo, rispose il Rango, perché costui metteva gridi da disperato, e se quei calzagatti di Guardie Nazionali avessero avuto un poco di coraggio ci avrebbero fatti a pezzi entro quelle strette vie.
– È vero? Tutto questo? L’avrà da fare con me. Contatemi il resto e fatemi capire se mai per parte vostra ci sia stato timore.
- Timore e di che? – rispose tronfio il Rango – di quei lavaceci dei suoi paesani? bah! quel timore che provano sei vecchi gattoni di un intero esercito di topi. Corpo di mille saette! Aveva voglia di battere quel maledetto tamburo, che noi ci trovavamo là sempre fermi al macchione. E quando appunto ci credevano di essere attorniati belli e buoni dalle Guardie Nazionali e dai soldati, non ci fu un maledetto cane che ci avesse latrato alle spalle.
- Bene! i nostri amici potenti hanno mantenuta la parola. Disse il Palma questo mi piace: viva l’onore! Viva il coraggio! Viva la compagnia! e lanciò il cappello in aria.
- Viva la compagnia! viva Palma! Gridarono nuovamente i briganti e scagliarono anch’essi in aria i loro cappelli.
- Bravi! Ripigliò il Capobanda con gioia feroce – io sono contento di voi tutti, perché vi siete fatti sempre onore. E perciò – Viva l’onore! viva la compagnia! –
- Evviva l’onore! viva Palma ripeterono tutti.
- Ed ora vuolsi far vedere a quelle marmotte – disse il palma quanto curiamo i loro tamburi e le loro tombe. Sì, spianate i vostri fucili e … fuoco!!! –
Ed una subitanea detonazione scosse il suolo, e l’aria impregnata di polvere fu inondata da un nugolo di fumo.
- Ripetete la carica, viva la compagnia! –
- Viva Palma esclamarono i banditi – Ed un’altra salva di fucilate rimbombò per le valli e per le pianure.
Dio! Dio! Quanto allora io soffriva, e quanto mi faceva male la gioia sparsa su quei volti abbruttiti! – Ed ora caricate di nuovo, perché si deve partire. Quattro di voi marceranno con me all’antiguardo, quattro al retroguarda, e quattro, cioè lo Zumpasco, Ramucelli, compare Pataracchio, e il rango condurrete il ricattato. Rango tu risponderai di tutto; e dopo avermi domandato se avevo bisogno di nulla, mi disse di stare con coraggio e di buon’animo fra loro, porgendomi la mano, che gli dovetti baciare.
Allora provai veramente tale una stretta di cuore che credetti doverne morire.
È vero, senza dubbio, che per me non vi era più scampo, ma fino a quando durò la fermata nella collina la città era sempre alla portata del mio sguardo; la mia casa era là fra quei mucchi di fabbriche mi credeva vicino ai miei. Ma quando mi fu imposto di partire credevo che fosse giunta per me l’ultima ora, ove avea lasciato quanto avea di più caro al mondo; mia madre. Datole un ultimo sguardo ed un addio seguii coll’anima annientata i mie conduttori, i quali con urtoni e spinte mi tuonavano sempre alle orecchie: cammina! E chi potrà ridire il trapazzo durato in quella notte? Ora si andava per valli ora per falsi piani, ed ora per aspri monti e dirupi, imboschiti fino alla cima.
Il brigante è il più implacabile nemico della civiltà, aborrisce l’uomo onesto e laborioso, perché a suo talento non è che un vile. Il brigante come il lupo si crede nato solo per assalire, rubare, sbranare, e rinselvarsi; e conserva l’istinto di questa belva feroce. Dopo che ha seminato la distruzione e la morte fugge nel più fitto della foresta, nei luoghi che più si configurano colla selvaggia natura della sua anima fosca; ed ivi si trova nella sua sfera. Se il brigante non fosse costretto a scendere dai monti nella pianura per appiattarsi presso la pubblica via, in una vecchia casa dirupata vicino all’abitato, presso un ponte, un fossato per svaligiare o ricattare i passanti non abbandonerebbe mai la fiera abitudine delle selve.
Da ciò si può indovinare come fosse andato quel notturno viaggio. Mi ricordo che evitavamo sempre le vie battute dei campi; e i luoghi colti, ed andavamo invece per boschi e valloni in cui i roveti ed i rami intrecciati dei rami faceano ombra densa ed estesa. Quelle ombre non rischiarate mai da un raggio di sole o di luna mi facevano orrore. Si era viaggiato tutta la notte ed ancora non veniva l’ora di fermarsi. Io aveva gonfiati i piedi, e mi tremavano le ginocchia, e non ne potevo più. Finalmente come a Dio piacque, il Capobanda ordinò la fermata nel centro del fitto bosco denominato Farneto. Quando ci fermammo spuntavano in oriente i primi fulgori dell’alba.
Fine della Giornata Prima
Per leggere l'intero diario è sufficiente eseguire questo download
Fu un rapimento, in un certo senso, anomalo per vari aspetti. Per saperne di più, suggerisco il seguente download (Il Processo)
I documenti di questa pagina sono online sul sito dell'Antica Biblioteca Corigliano Rossano (http://anticabibliotecacoriglianorossano.it). Per altri documenti importanti cliccare qui
 LA "MIA" CITTÀ: CORIGLIANO CALABRO
a cura di Giacinto De Pasquale
LA "MIA" CITTÀ: CORIGLIANO CALABRO
a cura di Giacinto De Pasquale